Skill Factory
Lista post > 9.Intelligenza Artificiale: cosa dobbiamo sapere su AI Act e deepfake
9.Intelligenza Artificiale: cosa dobbiamo sapere su AI Act e deepfake
![]() Gino Visciano |
Gino Visciano |
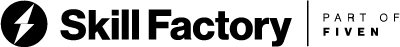 Skill Factory - 19/09/2025 11:23:20 | in Home
Skill Factory - 19/09/2025 11:23:20 | in Home
L’intelligenza artificiale (IA) ormai fa parte della nostra realtà quotidiana, per questo motivo è fondamentale conoscere le nuove regole europee e italiane che ne disciplinano lo l’uso sia nelle aziende, sia nelle scuole. Nel seguito approfondiremo l’AI Act, la normativa europea sull’IA, le specifiche leggi italiane sui deepfake e come queste norme si differenziano dal GDPR.

CHE COS’È L’AI ACT
L’AI Act è la legge europea che regola come creare, vendere e usare i sistemi di intelligenza artificiale. È stata adottata per garantire un uso sicuro, trasparente ed etico delle tecnologie IA, garantendo salute, sicurezza e diritti delle persone.
La legge distingue i sistemi IA in quattro categorie in base al rischio che possono comportare:
1. Sistemi vietati perché troppo pericolosi: Questi sono sistemi che rappresentano un rischio così elevato per la sicurezza, la privacy o i diritti umani da essere completamente proibiti. Ad esempio, tecnologie per la sorveglianza di massa senza autorizzazione o software che manipolano il comportamento delle persone in modo coercitivo rientrano in questa categoria.
2. Sistemi ad alto rischio che richiedono controlli rigorosi: Sono sistemi che, se usati in modo errato o male intenzionato, possono causare danni significativi a persone o proprietà. Per questo motivo devono essere sottoposti a procedure di verifica, test approfonditi e trasparenza nella loro implementazione. Un esempio tipico sono i sistemi di riconoscimento facciale usati per la sicurezza pubblica o le tecnologie che supportano decisioni in ambito sanitario.
3. Sistemi che devono solo fornire informazioni chiare (es. chatbot): Questi sistemi non presentano un alto rischio, ma devono assicurarsi di comunicare in modo trasparente e comprensibile all’utente, indicando ad esempio che si tratta di un’intelligenza artificiale e non di una persona. Un esempio è un chatbot che risponde a domande generali, dove è importante evitare fraintendimenti o aspettative errate.
4. Sistemi con rischi bassi o minimi per cui non servono particolari limitazioni: Sono sistemi che comportano pochi o nulla rischi per l’utente e la società, e quindi non richiedono regole o controlli specifici. Un esempio può essere un algoritmo che suggerisce ricette di cucina o che consiglia playlist musicali, che influiscono solo marginalmente sulle decisioni delle persone.

L’AI Act mira a creare un equilibrio tra la tutela della sicurezza, dei diritti fondamentali e della privacy delle persone e la promozione dell’innovazione tecnologica nel campo dell’intelligenza artificiale. Da un lato, introduce regole chiare e vincolanti per prevenire abusi, come l’uso di sistemi per sorveglianza invasiva o discriminazione automatizzata, tutelando così i cittadini da potenziali rischi e danni. Dall’altro, stabilisce criteri proporzionati che permettono alle aziende e ai ricercatori di sviluppare nuove applicazioni AI in modo responsabile, senza soffocare la crescita tecnologica. Questo bilanciamento è fondamentale per garantire che l’intelligenza artificiale possa offrire benefici concreti alla società mantenendo un controllo adeguato sui pericoli che potrebbe comportare.
QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA AI ACT?
Le sanzioni per chi non rispetta l'AI Act sono severe e variano in base alla gravità della violazione. Per le infrazioni più gravi, come l'uso di intelligenza artificiale manipolativa o pratiche vietate (es. sorveglianza biometrica illegale), le multe possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell'azienda, scegliendo la cifra maggiore. Per la non conformità relativa ai sistemi ad alto rischio, le sanzioni possono raggiungere i 15 milioni di euro o il 3% del fatturato globale. Infine, per la fornitura di informazioni false, incomplete o fuorvianti agli organismi di controllo, le multe possono essere fino a 7,5 milioni di euro o l'1% del fatturato mondiale.
Le PMI e le startup godono di un trattamento proporzionato con sanzioni ridotte rispetto alle grandi imprese, per tutelare l'innovazione senza penalizzare eccessivamente le realtà più piccole. Le sanzioni sono stabilite per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza nell'uso dell'intelligenza artificiale, oltre a prevenire abusi e rischi per persone e società. Le autorità nazionali e un organismo europeo dedicato sorvegliano l'applicazione del regolamento e possono intervenire con queste misure punitive in caso di inosservanza.
DIFFERENZE CON ALTRE NORMATIVE INTERNAZIONALI
Mentre in Europa c’è un regolamento unico e uniforme per tutti i Paesi membri, in Paesi come gli Stati Uniti le regole sono più frammentate e spesso basate sull’autoregolamentazione delle aziende.
L’UE punta a un approccio centrale e rigoroso, con un focus forte sull’etica, la tutela dei diritti e la trasparenza, diventando un modello per il resto del mondo.
Vantaggi di un regolamento unico e uniforme in Europa:
• Assicura coerenza normativa in tutti i Paesi membri, semplificando per aziende e cittadini la comprensione e l’applicazione delle regole;
• Rende più efficace la protezione dei diritti fondamentali, della privacy e dei principi etici, favorendo sistemi AI trasparenti e sicuri;
• Stimola la fiducia degli utenti nelle tecnologie AI, fondamentale per un loro utilizzo responsabile e consapevole;
• Posiziona l’Europa come riferimento globale per normative AI etiche e rigorose;
Esempio: Un’impresa sa che può sviluppare un sistema AI rispettando regole valide in tutta l’UE, facilitando l’accesso al mercato europeo.
Svantaggi di questo approccio:
• Le norme rigide possono rallentare il ritmo dell’innovazione e aumentare i costi di conformità, penalizzando soprattutto PMI e startup.
• Concorrenza più forte da Paesi con regolamentazioni più flessibili, come gli Stati Uniti, dove è possibile muoversi con maggior agilità.
• Complessità e risorse necessarie per l’applicazione e il monitoraggio del regolamento possono limitare l’efficacia e creare incertezze.
Esempio: una startup europea può rinunciare a sviluppare o lanciare prodotti AI per i costi e i tempi di adeguamento normativo, a vantaggio di competitor americani più agili.
L’Unione Europea con l’AI Act cerca di bilanciare protezione e innovazione, promuovendo un modello responsabile e affidabile, ma deve anche affrontare la sfida di non soffocare lo sviluppo tecnologico nel contesto competitivo globale.
DEEPFAKE E NORMATIVA ITALIANA
I deepfake sono contenuti audio o video manipolati dall’IA che possono essere usati per ingannare le persone. L’AI Act richiede che questi contenuti siano sempre chiaramente etichettati come artificiali.

L’Italia ha fatto un passo in più approvando nel 2025 una legge che rende reato la creazione e la diffusione di deepfake ingannevoli, con pene che vanno da 1 a 5 anni di reclusione. Questa normativa nasce dall’urgenza di proteggere la reputazione e la privacy delle persone, contrastando l’uso illecito di tecnologie capaci di manipolare immagini e video in modo tale da ingannare l’opinione pubblica o danneggiare individui specifici. La legge italiana si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i deepfake che possono alimentare disinformazione, frodi, diffamazione e violenza.
Oltre alla punizione penale, la legge prevede anche principi di rigorosa trasparenza: chi utilizza questi sistemi deve garantire che i contenuti creati siano identificabili come artificiali e non reali, in modo da evitare equivoci e danni a terzi. Questo approccio mira a rafforzare la fiducia nell’informazione e a tutelare i diritti fondamentali, come la dignità e la sicurezza personale.
L’implementazione della legge è sostenuta da un apparato di governance che coinvolge l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’Agenzia per l’Italia Digitale, chiamate a svolgere compiti di controllo, vigilanza e coordinamento. La normativa italiana amplia inoltre l’attenzione alla tutela del diritto d’autore, proteggendo le opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, per salvaguardare la creatività umana da usi impropri o fraudolenti.
Questo quadro legislativo rappresenta un esempio innovativo a livello mondiale di come normare comportamenti rischiosi legati all’intelligenza artificiale, combinando azioni penali con misure di trasparenza e prevenzione, al fine di garantire sicurezza, rispetto e responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie.
COME RICONOSCERE I DEEPFAKE
Per difendersi efficacemente, oltre alla legge, è importante sviluppare un atteggiamento critico e una buona educazione digitale, soprattutto nelle aziende e nelle scuole.
Conoscere la realtà e i meccanismi dei deepfake aiuta non solo a difendersi ma anche a capire meglio il valore dell’informazione vera e della responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale.
Il termine deepfake deriva dall’unione di “deep learning” (una tecnica avanzata di intelligenza artificiale) e “fake” (falso). Indica contenuti multimediali, come video, audio o immagini, manipolati digitalmente per far apparire qualcosa o qualcuno in modo diverso dalla realtà. Per esempio, un video deepfake può mostrare una persona mentre dice o fa cose che in realtà non ha mai detto o fatto.
I deepfake sono diventati più sofisticati e difficili da riconoscere, ma è importante imparare a difendersi per non cadere vittime di disinformazione o truffe.

Ecco alcuni suggerimenti per riconoscerli:
• Osserva attentamente i dettagli: immagini o video deepfake spesso presentano imperfezioni come movimenti innaturali, sfasamenti del labiale, luci o ombre incoerenti.
• Controlla la voce: audio manipolati possono avere tonalità inconsuete, pause strane o suoni metallici.
• Verifica la fonte: un video o immagine diffuso da fonti poco affidabili o anonime richiede sospetto.
• Usa strumenti di verifica: esistono software e servizi online che analizzano i file per rilevare possibili alterazioni.
• Fai attenzione ai contenuti sensazionalistici: spesso deepfake vengono usati per diffondere notizie false destinate a suscitare reazioni forti.
DIFFERENZE TRA AI ACT, LEGGE DEEPFAKE E GDPR
L’AI Act regola l’uso dell’IA su larga scala, mentre il DDL italiano si concentra sul fenomeno specifico dei deepfake, stabilendo reati e pene.
Il GDPR, invece, è la normativa sulla protezione dei dati personali. Essa si applica anche ai dati usati o generati dall’IA o dai deepfake, imponendo regole su sicurezza, consenso e trasparenza.
APPLICAZIONE E FORMAZIONE NELLE AZIENDE
L’AI Act e le leggi italiane sui deepfake rappresentano una risposta necessaria per usare l’intelligenza artificiale rispettando la sicurezza, la privacy e i diritti delle persone.
Per aziende e scuole, conformarsi a queste normative è una sfida ma anche un’opportunità per costruire fiducia, innovare responsabilmente e prepararsi a un futuro digitale più sicuro.
Formazione, trasparenza e governance sono quindi le chiavi per affrontare con successo il futuro dell’intelligenza artificiale.

Per le aziende rispettare queste norme significa:
• organizzare una governance chiara e responsabile dell’IA;
• formare i dipendenti sull’uso etico e sicuro delle tecnologie;
• assicurare trasparenza e controllo sui sistemi IA;
• rispettare la privacy e proteggere i dati;
• prepararsi a eventuali controlli delle autorità competenti.
Nelle scuole è fondamentale:
• educare studenti e personale a riconoscere contenuti falsi e manipolati;
• integrare l’IA in modo responsabile nella didattica;
• formare insegnanti su tecnologia, etica e regole;
• sviluppare nei giovani un approccio critico e digitale sicuro;
• collaborare con esperti e istituzioni per un aggiornamento continuo.
CONCLUSIONI
L’AI Act e la recente normativa italiana sui deepfake rappresentano tappe fondamentali per assicurare che l’intelligenza artificiale venga utilizzata in modo responsabile, sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali.
Queste norme non devono essere viste solo come vincoli legali, ma anche come opportunità per costruire fiducia, favorire l’innovazione responsabile e incrementare la sicurezza di cittadini e imprese.
Per le aziende e le scuole adeguarsi a queste regolamentazioni significa dotarsi di processi di governance efficaci e promuovere una formazione continua e capillare, che consenta a tutti gli attori coinvolti di conoscere rischi, obblighi e potenzialità dell’IA.
In particolare, la formazione e l’educazione digitale nelle scuole sono strumenti imprescindibili per formare cittadini consapevoli e critici, in grado di interagire in modo etico con le nuove tecnologie.
Affrontare con successo queste sfide normative significa prepararsi a un futuro dove IA, etica e diritti umani convivono, ponendo le basi per una società digitale inclusiva e sostenibile.
Infine, la conformità alle regole europee e nazionali può diventare un elemento distintivo e un vantaggio competitivo per chi saprà integrare tecnologia, sicurezza e responsabilità.
Nel prossimo articolo parleremo di come cambierà il mondo del lavoro con l'intelligenza artificiale
1.Intelligenza Artificiale: se la conosci non la temi
2.Intelligenza Artificiale: i modelli linguistici di grandi dimensioni
3.Intelligenza Artificiale: le reti neurali artificiali
4.Intelligenza Artificiale: tipi di reti neurali artificiali
5.Intelligenza Artificiale: IA Generativa
6.Intelligenza Artificiale: modelli pre-addestrati di IA locali
7.Intelligenza Artificiale: come creare una chatbot per conversare con Llama3
8.Intelligenza Artificiale: come addestrare LLAMA3 attraverso un Fine-Tuning di tipo no coding
10.Intelligenza Artificiale: Cosa cambia nel mondo del lavoro
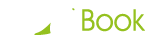




 Le Tue Aule
Le Tue Aule
 I Tuoi Gruppi
I Tuoi Gruppi
 Le Tue Selezioni
Le Tue Selezioni



 Scheda Azienda
Scheda Azienda